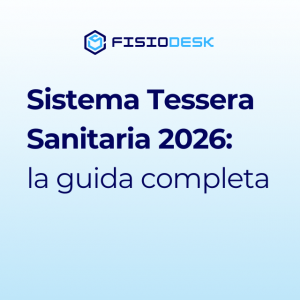Come sappiamo, le nostre cellule possiedono la capacità di riprodursi e specializzarsi, garantendo così un ricambio pressoché infinito delle più piccole unità funzionali del nostro organismo.
Tuttavia, questo non è il caso delle cellule nervose le quali, raggiunta la maturità neuronale, perdono tale funzione, diventando quindi estremamente preziose poiché, se danneggiate, non possono essere sostituite.
Sorge quindi spontanea una domanda: cosa succede al nostro cervello e alle sue cellule in caso di una lesione?
La risposta può sembrare scontata: vanno incontro a degenerazione, ma limitarsi a questo significherebbe non considerare i processi successivi alla lesione acuta (ictus, emorragia o trauma) che avvengono a livello neurale e che possono essere riassunti con il termine “neuroplasticità”.
Con essa si intende la capacità del sistema nervoso di adattare la propria struttura in risposta a una varietà di fattori e di stimoli interni o esterni, comprese le situazioni patogene acute.
Ponendo quindi il focus su quest’ultima parte, capiamo come la neuroplasticità possa essere sfruttata a vantaggio del trattamento riabilitativo a seguito di eventi infausti.
Cenni di neurofisiologia
Alla base del concetto di neuroplasticità vi sono eventi che accadono a livello microscopico, i quali influenzano e determinano la modifica di connessioni neurali e, in modo più ampio, di connessioni tra aree del cervello.
Lo psicologo canadese D. Hebb fu probabilmente tra i primi a ipotizzare che l’attività di un neurone potesse influenzare quella delle cellule nervose a lui adiacenti e connesse e, sulla base di questo, formulò il principio che porta il suo nome:
“Se l’assone di un neurone A è abbastanza vicino per eccitare un altro neurone B in modo ripetuto e consistente, in uno o in entrambi i neuroni si producono cambiamenti metabolici e un processo di crescita per cui l’efficienza dei neuroni risulta potenziata.”
Cambiamenti nella potenza della connessione sinaptica possono essere temporanei o duraturi a seconda dell’intensità e del ripetersi dello stimolo eccitatorio che la interessa: i cambiamenti temporanei sono caratterizzati da modifiche a livello biochimico e consistono nel rilascio di una maggiore quantità di neurotrasmettitore, nell’attivazione di nuovi recettori postsinaptici o nella modifica di recettori già presenti; affinché il cambiamento sia duraturo, però, la modifica deve avvenire a livello strutturale.
Nello specifico, tre sono i principali fenomeni con i quali il nostro cervello modifica strutturalmente le proprie cellule:
- Sprouting collaterale o gemmazione dendritica: un neurone crea nuove sinapsi attraverso la formazione di rami dendritici, stabilendo quindi nuove connessioni.
- Smascheramento delle sinapsi latenti: ogni neurone possiede migliaia di sinapsi con altri neuroni; tuttavia, solo alcune di queste sono attive, mentre molte vengono definite latenti. Quando insorge una lesione o un danno, vi è l’attivazione di queste sinapsi per mantenere attive le connessioni neurali.
- Riorganizzazione delle aree corticali: aree cerebrali, anche distanti tra loro e con compiti differenti, a seguito di una lesione si riorganizzano per sopperire alle funzioni perse.
L’apprendimento motorio
Con apprendimento motorio si definisce quel processo in cui la capacità di controllo motorio specializzato viene rappresentata dalla memoria, che è il prodotto dell’apprendimento. Il nostro sistema motorio, in stretta collaborazione con il sistema nervoso, ha la capacità di apprendere attraverso la pratica e l’esperienza, portando a modificazioni permanenti nell’abilità di produrre movimenti finalizzati.
L’apprendimento motorio consta di due tipi distinti di apprendimento:
- Adattamento motorio: è il processo attraverso il quale si adegua un movimento (o schema motorio) a nuove richieste attraverso una pratica per tentativi ed errori; è un processo di apprendimento a breve termine che consente un controllo flessibile del movimento.
- Acquisizione di abilità: acquisizione e successivo affinamento di nuove combinazioni di sequenze di movimenti; è legato alla memoria a lungo termine e si correla a miglioramenti della prestazione nel tempo.
L’apprendimento può essere influenzato da diversi fattori come il sonno, la quantità di esercizio (intensità, volume, ripetizione e tempo) e l’importanza del compito richiesto (motivazione).
L’importanza del trattamento fisioterapico
Compresi i principi alla base del rimodellamento neurale a seguito di un danno cerebrale e introdotto il concetto di apprendimento motorio, possiamo calarci in ambito fisioterapico cercando di unire concetti neurofisiologici e trattamento al fine di ricercare un miglioramento nel paziente che abbiamo in carico.
Iniziamo affermando che ad oggi il metodo principe per attivare i processi di plasticità neuronale finalizzati al recupero funzionale è l’esercizio attivo. Esso consta fondamentalmente di tre aspetti i quali entrano in interazione tra loro: soggetto, compito e ambiente.
Seguendo i principi dell’apprendimento motorio possiamo andare a manipolare in maniera selettiva soggetto, compito o ambiente al fine di influenzare le modifiche neuroplastiche a lungo termine e di conseguenza promuovere la performance motoria dei pazienti.
Nonostante eventi lesivi acuti come ictus, emorragie o traumi solitamente risultino in deficit importanti che compromettono l’autonomia del paziente nell’esecuzione di attività della vita quotidiana e, più in generale, la qualità di vita, la fisioterapia rimane uno strumento fondamentale nel trattamento riabilitativo.
Se seguito da un team multidisciplinare, il soggetto può puntare a un miglioramento della performance e a un recupero funzionale.
Articolo scritto in collaborazione con Alessandro Negri